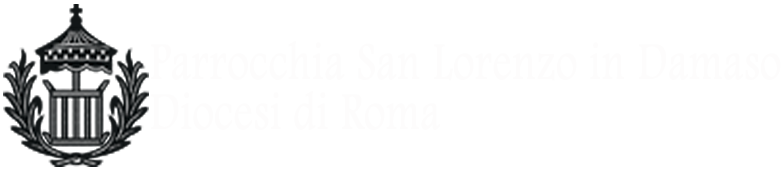Crocefisso Ligneo – sec. XIV

Scuola Romana – seconda metà del sec. XIV
Nella Cappella del Crocifisso costituita nel 1582, è posto sull’altare un crocifisso ligneo policromo, Gesù viene raffigurato con il capo reclinato e coronato di spine, i chiodi trafiggono il palmo delle mani e i piedi sovrapposti; il viso è atteggiato ad una espressività serena, successiva agli atroci spasmi dell’agonia e riflette nella struttura scultorea un’anatomia essenziale nelle braccia, nel torace e nell’addome, segnata da un perizoma dal pesante e rigido panneggio, seguendo un linguaggio di derivazione scultorea romana classica costantemente presente nella formazione degli artisti operanti nella città. L’ebanista che ha realizzato il crocifisso nel XIV secolo definisce la costruzione dell’immagine, nei caratteri formali plastici in cui si evidenzia il dolente e silente consummatum est, testimonianza della salvezza dal peccato degli uomini attraverso la morte e la resurrezione del figlio di Dio. La scultura lignea di scuola romana, nel linguaggio figurativo dell’imago Christi, della seconda metà del trecento, si allinea in valore e qualità artistica, con i più noti esempi di crocifissioni tardo medioevali conosciute nelle aree umbre e toscane.  Nella basilica di San Lorenzo in Damaso nel XVI secolo, il Cristo erasituato in prossimità della cappella del Sacramento, nel 1603 la croce fu posta nell’attuale collocazione e in tale circostanza subì dei ritocchi conservativi e venne corredata dal cartiglio accartocciato in cui è inscritto il titulus Cristi INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum). L’intervento di restauro dell’anno 2000 ha contribuito ad eliminare patine e velature (Ádám Poós, San Lorenzo in Damaso, Roma 2015 pp.108-109). Nelle narrazioni storico critiche della chiesa il Crocifisso damasiano è posto in relazione con il soggiorno romano di Brigida di Svezia, [negli anni difficili della guerra dei Cent’anni (1339-1453)], nel suo cammino religioso giunse a Roma nel 1350 in occasione del Giubileo, ed alloggiò in una abitazione limitrofa alla chiesa di San Lorenzo in Damaso. Nel complesso architettonico medioevale degli ambienti adiacenti alla chiesa, la santa poteva agevolmente raccogliersi in preghiera meditativa davanti al Crocifisso, che diviene un perno dell’evoluzione della dialettica cristologica di Brigida che si esprime concretamente nella stesura delle Rivelazioni.
Nella basilica di San Lorenzo in Damaso nel XVI secolo, il Cristo erasituato in prossimità della cappella del Sacramento, nel 1603 la croce fu posta nell’attuale collocazione e in tale circostanza subì dei ritocchi conservativi e venne corredata dal cartiglio accartocciato in cui è inscritto il titulus Cristi INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum). L’intervento di restauro dell’anno 2000 ha contribuito ad eliminare patine e velature (Ádám Poós, San Lorenzo in Damaso, Roma 2015 pp.108-109). Nelle narrazioni storico critiche della chiesa il Crocifisso damasiano è posto in relazione con il soggiorno romano di Brigida di Svezia, [negli anni difficili della guerra dei Cent’anni (1339-1453)], nel suo cammino religioso giunse a Roma nel 1350 in occasione del Giubileo, ed alloggiò in una abitazione limitrofa alla chiesa di San Lorenzo in Damaso. Nel complesso architettonico medioevale degli ambienti adiacenti alla chiesa, la santa poteva agevolmente raccogliersi in preghiera meditativa davanti al Crocifisso, che diviene un perno dell’evoluzione della dialettica cristologica di Brigida che si esprime concretamente nella stesura delle Rivelazioni.  L’immagine damasiana della passione e morte di Gesù, si inserisce nell’ambito della cultura cristologica medioevale come cardine dialettico che trova il suo primo momento di divulgazione cultuale nel crocifisso di San Damiano (conservato nella Basilica di Santa Chiara ad Assisi) che permea l’esperienza mistica di Francesco d’Assisi, impetrando un discorso fideistico di costante attualità.
L’immagine damasiana della passione e morte di Gesù, si inserisce nell’ambito della cultura cristologica medioevale come cardine dialettico che trova il suo primo momento di divulgazione cultuale nel crocifisso di San Damiano (conservato nella Basilica di Santa Chiara ad Assisi) che permea l’esperienza mistica di Francesco d’Assisi, impetrando un discorso fideistico di costante attualità.